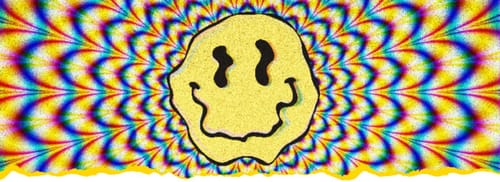
Critica psichedelica alla psichiatria
Jacobin Italia - Thursday, July 17, 2025 Articolo di Giulia Giraudo
Articolo di Giulia GiraudoLibri, incontri, festival e convegni sono nati negli ultimi anni mettendo al centro il tema della salute mentale e una forte critica al sistema dominante di controllo e disciplinamento dei soggetti, tra questi il libro di Piero Cipriano (La salute mentale è politica, Fuoriscena, 2025) psichiatra e che ha trascorso diciassette anni in un Spdc (Servizio psichiatrico diagnosi e cura) romano. Cipriano fa parte di un movimento nato in maniera più o meno spontanea all’interno del variegato e complesso mondo della salute mentale in cui si interfacciano soggetti con diverse competenze e storie di vita (dallo psichiatra all’infermiera, dalla psicoterapeuta allo studente di psicologia o il professore universitario, fino ai collettivi nati, come nel caso delle Brigate Basaglia, per rispondere alla crisi della salute mentale durante la crisi pandemica).
Queste soggettività, che si muovono singolarmente o in gruppo, denunciano condizioni di lavoro insostenibili, un sistema incapace di rispondere realmente ai bisogni delle persone e una cultura e un sapere psichiatrico che deve essere ripensato e criticato a partire dalla relazione che stabilisce con il paziente. O per meglio dire, a partire dalla costruzione del paziente, etichettato e definito attraverso parole che ne costruiscono l’identità, contenendolo in una «camicia forzata» che lo obbliga a muoversi in precisi ambienti e spazi in cui l’uso degli psicofarmaci è una regola a cui adeguarsi. Un sapere che può e deve essere rigenerato anche grazie alla relazione con altre culture e tradizioni che hanno vissuto storie fatte di emergenze specifiche prodotte dallo stesso schema di rapporti di potere, espressione della natura violenta di un capitale che agisce sui singoli a diversi livelli e con diversa intensità. La violenza che uomini e donne vivono, infatti, non si esaurisce nella violenza delle guerre o del genocidio, ma si costruisce anche per mezzo del linguaggio o di forme di controllo spacciate per strumenti di libertà che esauriscono le esistenze nel quotidiano.
Tra le forme di controllo, centrale è il consumo delle merci e quindi degli psicofarmaci venduti come rimedio per resistere, o meglio per costruire menti che si adattano. Così come sono centrali le parole, come il termine «resilienza» che predispone strumenti per un soggetto che costruisce individualmente strategie per resistere all’interno di un sistema che produce diseguaglianze e ingiustizie, accettando le condizioni date.
La scelta della resilienza, l’opzione degli psicofarmaci, l’adeguamento della psichiatria a ruolo di ancella nell’integrazione del soggetto nella società non è nuovo, ma nuova è la critica che nasce dentro alle discipline (la psichiatria e le discipline psicologiche), grazie a voci autorevoli. Si pensi a appunto al libro di Cipriano o a quello di Contestabile (Psicologia della resistenza, Effequ,2024) che in quanto dottorando in psicologia ha sviluppato una propria visione critica che cresce nella relazione (e nella partecipazione) con i collettivi che sul territorio si organizzano per riflettere sul proprio lavoro, sulle conseguenze di una formazione che non risponde alle legittime richieste di cura e emancipazione dei soggetti che soffrono.
Queste voci di singoli e collettivi si muovono all’interno di diversi campi del sapere. La crisi del sapere «occidentale» è del resto oggi componente essenziale di una policrisi che nasce a partire dall’atteggiamento di chiusura e pretesa di superiorità: non si tratta, secondo questi soggetti, di rifiutare ogni aspetto del sapere egemone, ma di criticarlo grazie e nuovi linguaggi e pratiche sociali che possono nascere da relazioni impreviste.
Oltre e in relazione a queste critiche, da tempo si è sviluppato un interesse non nuovo nei confronti di sostanze che potrebbero supportare i soggetti che soffrono (perché sì, la malattia mentale produce sofferenza concreta, dolore mentale e fisico che isola, debilita, costringe il potenziale dei soggetti in una camicia di forza mentale che spesso non permette di immaginare forme di liberazione) a costruire ponti, pensieri e schemi diversi, altre realtà nelle quali immaginare strumenti e azioni per contrastare la sofferenza. Non si tratta di fantascienza, ma di alcune sostanze psichedeliche che in passato sono state studiate e anche assunte dagli studiosi e che nel tempo sono diventate parte di una cultura (variegata) che è stata criminalizzata e repressa.
Questo è avvenuto in tutto il «civile» mondo occidentale, ma nel nostro paese l’approccio alle sostanze ha assunto un accanimento peculiare, moralizzante, una criminalizzazione, uno stigma che ha prodotto conseguenze nefaste non solo sui soggetti che ne hanno fatto (o ne fanno) uso, ma per la possibilità stessa di uno studio scientifico di queste sostanze che possa permettere, attraverso la ricerca, di salvare vite umane. Salvare una vita, quando si parla di salute mentale, significa darle dignità, salvarla dalla sofferenza, lasciare la libertà di scelta al soggetto. La libertà, proprio quella parola che il «capitale» ha fatto propria: una libertà di consumare le sostanze che sono etichettate come legali (si pensi all’alcool) ma non quelle che possono liberare le coscienze e rendere difficile il loro controllo.
Nel campo della salute mentale, nonostante i controlli e i limiti, gli studiosi stanno svolgendo ricerche che necessitano di finanziamenti e legittimità. Sul piano pubblico e politico, si registra un rinnovato attivismo rispetto a questi temi in quel variegato mondo associativo attento alla salute mentale che da anni studia e si occupa di divulgazione di ricerche su terapie e prospettive di cura: dalle associazioni di professionisti della salute mentale, passando per la Simepsi, l’associazione creata attorno al podcast «illuminismo psichedelico» e Maps Italia, Associazione multidisciplinare per gli studi psichedelici non profit e indipendente che lavora per aumentare la consapevolezza e la comprensione delle sostanze psichedeliche, fino ai canali social di divulgazione scientifica del progetto studio Aegle.
In relazione a queste realtà, l’Associazione Luca Coscioni sta provando a costruire spazi di discussione a partire dalle cellule territoriali di cui è dotata e attraverso la campagna PsychedeliCare, iniziativa civica europea sugli psichedelici che tra le altre cose chiede una linea di bilancio dedicata alla ricerca per fini medici. Le cellule territoriali stanno costruendo momenti di riflessione e formazione sul tema. La raccolta firme per la campagna prosegue e si accompagna alla lettera pubblicata dall’associazione nel 2024 e firmata da 170 esponenti del mondo della scienza, rivolta ai Ministri della Salute e della Difesa: nella lettera si chiede di riconoscere gli psichedelici come terapie per alcune condizioni specifiche.
Vista la mancata risposta dei ministri Orazio Schillaci e Guido Crosetto, l’Associazione ha lanciato l’appello pubblico «L’Italia apra alle terapie psichedeliche» a sostegno della lettera a loro indirizzata. Questa campagna, che si muove su diversi piani, può essere l’occasione per informarsi, capire, confrontarsi e anche per far emergere le legittime paure che sono interne e costitutive di una prospettiva per noi così nuova e fuori dagli schemi attraverso cui formiamo il nostro pensiero sul mondo. Per questo rimando al sito dell’Associazione dove è possibile trovare il materiale di riferimento, gli studi e la normativa italiana.
Questo è il futuro, o per meglio dire il presente, che ci auguriamo, quello che nasce nella relazione imprevista tra soggetti che si trovano ad agire in un clima di nuovi bisogni e richieste, di sofferenza ma anche possibilità di informarsi e provare a costruire pratiche nuove. Questo però non basta: serve la volontà politica, quella stessa che riduce il «fine vita» a una questione privata, che taglia i fondi alla ricerca e alimenta disuguaglianze e ingiustizie. Quella stessa volontà politica che ha definito un mondo nel quale le sostanze psichedeliche sono state indistintamente identificate come «pericolose», così come quei saperi del Sud globale o della tradizione popolare che sono stati maltrattati, sminuiti, infantilizzati.
Abbiamo oggi la possibilità di contaminare il sapere in crisi di legittimità con conoscenze diverse che nutrono le nostre menti e, nel caso della salute mentale, possono aprire percorsi di cura innovative, speranze di «sol dell’avvenire» per i tanti e le tante che vivono dipendendo da uno o più psicofarmaci. Quello stesso psicofarmaco che è prodotto da una casa farmaceutica che lucra sulle vite delle persone. La salute mentale ci obbliga a guardare alla complessità della realtà, a guardare alla politica in relazione all’economia, all’organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
La nostra salute mentale, la nostra sofferenza, è il sintomo che qualcosa non funziona: non deve essere silenziato, ma compreso, non deve essere contenuto, ma inteso come una critica all’esistente che non riesce a esprimersi diversamente.
È un’occasione per ripensarci, per pensare e rispondere alle richieste di chi vive la sofferenza, nell’ottica di costruire una società in cui la cura non sia solo uno slogan, ma una pratica politica quotidiana a partire dal movimento di corpi e menti che criticano un sapere che vuole il controllo e la disciplina e non libera la potenza dei soggetti.
*Giulia Giraudo, dottoranda in mutamento sociale e politico, si è occupata di precarietà, con un focus sul collettivo San Precario.
L'articolo Critica psichedelica alla psichiatria proviene da Jacobin Italia.
