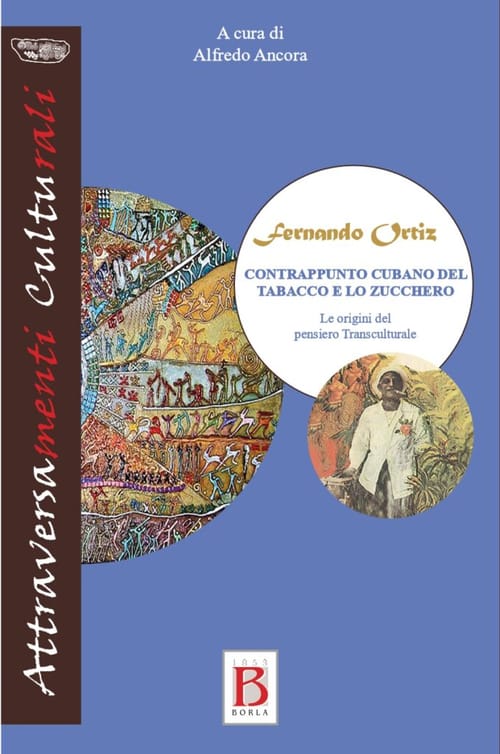
Oltre il pensiero unico
Comune-info - Tuesday, July 1, 2025Don tabacco, Donna Zucchera e la cultura come processo in continuo divenire. Le origini del pensiero transculturale

Antropologo ed etno musicologo Ferdinando Ortiz Fernández (La Havana,1881 – 1969), candidato al Premio Nobel della pace nel 1955, è stato fra i maggiori innovatori del pensiero antropologico del novecento.
Nel dibattito attuale, in cui incombe la minaccia di un pensiero unico che vorrebbe appiattire ogni dissenso e ogni canale di confronto culturale, ci sembra importante e opportuno riproporre l‘opera di Ferdinando Ortiz Contrappunto cubano del tabacco e lo zucchero, le origini del pensiero transculturale (Borla 2025). In essa viene messo a fuoco il concetto di transculturacion, ossia l’attraversamento di culture e la loro reciprocità con la pratica del “toma y daca”, “prendi e dai”. L’obiettivo del saggio è di esporre mediante una analisi – per contrappunto – la sua teoria sui fenomeni di commistione e contatto di mondi differenti (creolo, castigliano, caraibico etc.) che si influenzano vicendevolmente senza che uno si imponga sull’altro. Il titolo Contrappunto– ponere punctum contra punctum – (segnare nota contro nota)è coniato dal linguaggio musicale per indicare la presenza in una composizione o in una sua parte di linee melodiche indipendenti. Come riferisce l‘antropologo del suono Antonello Coliberti (2016), “il contrappunto si concentra sull’aspetto melodico piuttosto che sull’effetto armonico; la chiave è tutta nell’indipendenza delle diverse voci”.
Da questa contrapposizione di note può nascere una polifonia come risultato di elementi diversi e di differente valore. Il contrappunto salta il discorso gerarchico delle note. Ortiz parte da questo linguaggio musicale per introdurre la storia di due prodotti caratteristici dell’isola, tabacco e zucchero, divenuti due “personaggi litigiosi” pur se dialoganti. Nel presentarli ricorre alla metafora musicale per descriverne differenze e contrasti dei rispettivi mondi di appartenenza, e come per le note, senza che l‘una prevalga sull’altra. Dal loro incontro si ricevono e si lasciano codici, senza paura di perdere i propri. Come è noto zucchero e tabacco nella realtà sono due prodotti differenti a livello economico e a livello sociale, ognuno con sue proprietà specifiche. Nella suggestiva raffigurazione dell’autore prendono le sembianze di due personaggi particolari della narrazione cubana: Don tabacco e Donna Zucchera (azúcar in spagnolo è anche femminile). Il tabacco è amaro e possiede un aroma, lo zucchero è dolce e non ha odore, il tabacco è audacia, lo zucchero è prudenza. Il tabacco è maschile, lo zucchero è femminile e innumerevoli altre pittoresche rappresentazioni. L’etnomusicologo Ferdinando Ortiz attinge a queste figure fantasiose, radicate nelle tradizioni dell’isola, per evidenziarne contraddizioni e allo stesso tempo varietà e ricchezza. Non c’è spazio per culture superiori. Né “subalterne”, come direbbe Antonio Gramsci. Le osservazioni metodologiche di Ortiz nascono “sul campo” (secondo gli insegnamenti del suo maestro Malinowski) in una Cuba meticcia degli anni Quaranta, aperta alle correnti di tanti mondi che si intercettavano influenzandosi e contaminandosi reciprocamente. Nel particolare spaccato della società cubana di quel periodo si erano infatti formate le condizioni per una mescolamento di culture, secondo un processo creativo e dinamico frutto delle interazioni fra le popolazioni che pullulavano nell’isola, ognuna con i suoi riti, costumi, lingua. Cuba rappresentava come dice Valerio Riva nella sua nota storica al testo (2025, cit.) la “prefigurazione della futura società universale, di un mondo nuovo dove tutte le “razze” si sarebbero mescolate. Riconoscere a ognuna di esse dignità e singolarità e considerarla sullo stesso piano delle altre rappresentava un duro attacco a ogni forma di etnocentrismo, presente ai suoi tempi e ancora duro morire ai giorni d’oggi, se pur “sotto mentite spoglie”.
Il suo metodo risultò rivoluzionario per quel periodo e si diffuse in molti paesi suscitando l’interesse fra gli antropologi: latransculturazione superava concetti come “acculturazione o “differenziazione” fino ad allora adottati nel dibattito scientifico. Attualmente vorremmo sottolineare soprattutto i suoi aspetti dinamici e il potere trasformativo. Infatti con la preposizione trans si vuole mettere in risalto la processualità dell’incontro durante il quale si lasciano e si prendono elementi culturali con un arricchimento reciproco. Nel passaggio attraverso altri modi e mondi di conoscenza si possono modificare atteggiamenti mentali chiusi e rigidi della ricerca, della cura, ed in ogni contesto in cui sono necessari apertura e flessibilità. In tale transito si assiste a “contaminazioni” e adattamenti che ogni tipo di siffatti incontri sollecita e provoca. L’opera dell’antropologo cubano è importante anche perché riconosce alla cultura il suo carattere processuale, di divenire più che di divenuto, lontano dalle sirene di esotismi “etno” molto di moda. Il pensiero transculturale offre una chiave di lettura per un mondo plurale, in continuo movimento, dove categorie “etichettanti” non sono sufficienti all’operatore transculturale del terzo millennio di fronte a fenomeni complessi con cui si trova d interagire. Un diverso approccio nella pratica quotidiana con migranti e i rifugiati lo aiuterebbe a considerarli non solo nei loro aspetti sociali ed economici (oltre che umani) ma anche come rappresentanti di altri mondi con cui rapportarsi “dando e ricevendo” senza rischi per la propria integrità. Il mondo è in continua evoluzione e insieme a esso si trasformano le culture e il modo con cui impattano sulla vita degli individui.
Ortiz introdusse una visione innovativa basata su un concetto rivoluzionario rispetto ai metodi tradizionali legati (non solo allora) a una visione culturocentrica, secondo cui ogni cultura si ritiene centrale rispetto alle altre, ”periferiche”. Egli offre una prospettiva transculturale aperta a varie derive: clinica, storica, antropologica, psicologica, di ricerca. Il suo testo fa anche riflettere sull’importanza di costruire un pensiero mobile atto a intercettare più che a difendersi, pronto a un nomadismo di pensiero/azione per varcare le cosiddette “soglie di competenza” che spesso bloccano i processi evolutivi in molti ambiti. Nella società che si va configurando non è sufficiente attenersi a un mandato “neutro”, “istituzionale”, trascurando movimenti interni-esterni che ogni processo culturale richiede e produce. A latere bisogna aggiungere che per molto tempo nell’analizzare la sua opera si è soffermati più sugli aspetti positivisti (nel suo primo periodo era stato molto influenzato dal pensiero del criminologo Cesare Lombroso) che sugli gli aspetti innovativi del suo pensiero. Don Ferdinando – come lo chiamava Malinowski – non era solo un intellettuale immerso nei libri, avulso dalla società, ma un uomo impegnato nella attività politica di Cuba del tempo, tanto da militare come deputato nella sinistra liberale, e combattere contro ogni attacco alla democrazia nella sua isola, a fianco degli studenti nelle loro manifestazioni antifasciste. In seguito soffocato dal clima autoritario e repressivo, creato dal dittatore Machado, il Mussolini dei Caraibi, lasciò per protesta l’incarico di parlamentare e andò in esilio a New York, “traslocando con libri, idoli e tamburi”. Pur ricordando le sue contraddizioni (positivista e rivoluzionario) lo consideriamo un punto di riferimento fondamentale per lo psichiatra, psicologo e psicoterapeuta transculturale che attraversa modi e mondi della sofferenza, senza separarli dai loro contesti culturali e sociali e conseguentemente riesce a mettersi in discussione, sospendendo categorie non sintoniche con le realtà che va a conoscere. Come direbbe Foucault (2023): “Il pensare è il fuori dall’accademia, come il conoscere, ben oltre il comprendere, è prendere posizione”.
L'articolo Oltre il pensiero unico proviene da Comune-info.
