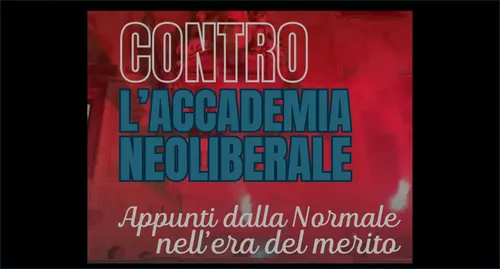
Contro l’accademia neoliberale: appunti dalla Normale nell’era del merito
ROARS - Friday, November 7, 2025Riprendiamo l’articolo del Collettivo della Scuola Normale Superiore apparso qui. Buona lettura.
È arrivato novembre. Un altro anno accademico si è aperto e ancora una volta la cerimonia d’inaugurazione della Scuola Normale si è svolta senza alcuno spazio di parola studentesco – una singolarità, se si considera che in pressoché ogni università questo momento coinvolge anche chi l’università la vive quotidianamente.
Le lezioni ricominciano e sentiamo la necessità di dotarci di strumenti per leggere la realtà che stiamo vivendo. Negli ultimi mesi, nelle assemblee del Collettivo, nelle mobilitazioni contro la riforma Bernini e nelle discussioni quotidiane nelle classi della Scuola, è emersa una consapevolezza sempre più nitida: le trasformazioni che attraversano l’università non arrivano mai come fratture improvvise, ma si sedimentano nel quotidiano, si insinuano attraverso piccole modifiche ai regolamenti, irrigidimenti formali che cambiano gradualmente il nostro modo di studiare, di organizzarci, di esistere come comunità accademica.
Con questo articolo proviamo a condividere alcune riflessioni con l’intento di restituire un’immagine più chiara del contesto in cui viviamo e prendiamo parola: perché è proprio nelle pieghe della normalità amministrativa che si rende visibile il progetto di un’università neoliberale e piegata alle logiche del profitto — e dunque è in questi dettagli che dobbiamo imparare a guardare per riconoscere il presente e immaginare come trasformarlo.
Negli ultimi decenni l’università italiana è stata progressivamente riscritta secondo il lessico e le logiche del neoliberismo, un progetto politico ed economico che ha riorganizzato le società occidentali attorno al presunto modello “naturale” e “inevitabile” dell’economia di mercato, assorbendo nelle sue dinamiche istituzioni e diritti un tempo sottratti alla competizione: dalla sanità alla famiglia, dalla scuola alla casa. Per accademia neoliberale intendiamo, dunque, l’insieme di riforme e di discorsi che hanno via via piegato l’università a questa ambizione. In questo quadro abbiamo assistito all’espansione di criteri di efficienza, di valutazione continua, di competizione e misurabilità, che hanno trasformato la formazione e la ricerca in prestazioni quantificabili e la comunità studentesca e docente in una somma di individui chiamati a ottimizzare il proprio percorso in vista della competitività complessiva dell’istituzione.
Non si tratta soltanto di un processo di riforma amministrativa o di trasformazione gestionale, ma di una mutazione profonda del modo stesso in cui il sapere viene prodotto, legittimato e distribuito. L’università, anziché pensarsi come spazio di elaborazione culturale e di emancipazione sociale, assume gli strumenti dell’impresa: indicatori di performance, “attrattività” per investitori, culto per il ranking. Il sottofinanziamento strutturale, invece che denunciato come scelta politica che smantella l’autonomia del sapere, viene rovesciato in narrazione meritocratica: chi “sa fare di più con meno” sarebbe moderno, virtuoso, efficiente. E così la dipendenza da finanziamenti privati viene normalizzata come orizzonte inevitabile. Questi processi colpiscono non solo student3 ma anche docenti e ricercator3 attraverso precarietà strutturale, carriere frammentate, valutazioni quantitative, adattamento forzato delle linee di ricerca agli interessi economici dominanti.
Questo quadro produce effetti concreti sulla vita accademica. L’accesso allo studio si trasforma in competizione e la retorica del merito funziona come dispositivo di legittimazione dell’esclusione. Si naturalizza la figura dello studente-imprenditore di sé, che deve sacrificarsi, performare, distinguersi per guadagnarsi un posto, mentre il diritto allo studio diventa un privilegio da meritare e non un fondamento della cittadinanza democratica. L’immaginario aziendalista entra nei corridoi universitari e li popola di parole come “eccellenza”, “attrattività”, “competitività”, che spesso oscurano la domanda fondamentale: a chi e per chi serve il sapere che produciamo? 1
Come normalist3 ci chiediamo oggi in che modo le logiche neoliberali si manifestano nella nostra istituzione. Qui il sottofinanziamento non si percepisce con la stessa intensità di altre università italiane; e tuttavia questo apparente scarto non ci sottrae al modello, anzi lo rende talvolta più silenzioso e pervasivo. Il privilegio materiale può funzionare come schermo che oscura le trasformazioni in corso, o peggio come giustificazione implicita: se “qui funziona”, allora il paradigma competitivo, selettivo e aziendalizzato sarebbe legittimo. Ma a quale prezzo? E per chi?
Quest’autunno la direzione della Scuola ha avviato un processo di revisione dei regolamenti, intervenendo in modo significativo soprattutto sulla classe di Lettere. Ciò che percepiamo è l’ennesimo passo dentro un percorso già tracciato negli anni passati: la progressiva standardizzazione delle carriere e della didattica per aderire ai parametri ANVUR e ai dispositivi europei di accreditamento.
Là dove la formazione si voleva costruita attraverso una relazione diretta tra student3 e docenti, e dove il percorso accademico conservava un margine di autodeterminazione, oggi prende forma un’architettura rigida e modulare. La distinzione tra seminari “afferenti” e “non afferenti” è diventata il primo passo verso un modello in cui la scelta dell3 student3 viene sacrificata in nome della misurabilità. Per ottenere fondi, per essere riconosciut3 come “eccellenza”, dobbiamo diventare incasellabili, leggibili da organismi che non vivono la nostra realtà ma la definiscono.
Un segnale evidente di questa trasformazione è la programmazione didattica. I corsi annuali, che costituivano l’ossatura tradizionale della formazione in Normale, lasciano spazio a moduli brevi da 20 ore (3 cfu), presentati come soluzioni temporanee per “tappare i buchi” (espressione pronunciata in consiglio di classe dal corpo docente) dopo il pensionamento di tre professori ordinari. Eppure, più che una contingenza, ci sembra emergere un cambio di paradigma: una didattica frammentata, affidata a figure chiamate per pochi mesi, senza continuità progettuale né responsabilità educativa di lungo periodo e che non dispongono nemmeno delle condizioni contrattuali per poter assumere un ruolo pieno nella nostra formazione — per esempio accompagnandoci come relatori interni nei colloqui.
La nostra comunità era costruita – almeno in teoria – sulla presenza di docenti interni, responsabili della nostra crescita intellettuale e disponibili ad accompagnarci nei momenti cruciali del percorso accademico. Oggi assistiamo alla chiusura rapida dei contratti dei docenti esterni, alla lentezza nell’assunzione di nuovi ordinari e, parallelamente, alla facilità con cui si attivano incarichi brevi e discontinui. Il risultato è un’istituzione che si presenta rinnovata, “fresca”, pronta a offrire molti corsi nuovi, ma priva di una struttura solida che renda possibile una formazione effettiva. In questa stessa direzione si è mosso anche l’indurimento delle pratiche valutative: in più sedi è stata rivendicata dai professori l’esigenza di rendere la dinamica del voto più differenziata. È un dettaglio che dice molto: valutare e distinguere è sempre più urgente in un’accademia sottofinanziata che potrà accogliere sempre meno di noi. Troviamo molto ironico che il nostro direttore – che si rifiuta di confrontarsi con la comunità studentesca su ogni tema – abbia appena dichiarato che “alla Normale cerchiamo di dare il meno possibile voti”.
Questo dinamismo apparente si ammanta di parole seducenti: interdisciplinarità, apertura, internazionalizzazione. Nascono così corsi come “studi di genere” e “culture di minoranza”, potenzialmente preziosi, ma organizzati come una parata di docenti che terranno poche lezioni, in inglese, senza alcuna continuità né progettualità. Nel caso di “culture di minoranza” si arriva al paradosso di dieci lezioni da due ore, tutte affidate a docenti divers3 e su argomenti differenti. Qui non conta davvero la coerenza della formazione, sembra invece prevalere l’urgenza di esibire la capacità della Scuola di farsi promotrice di temi “progressisti”, una strategia che appare più legata alla visibilità nel network EELISA che alla costruzione di un sapere critico e stabile. La domanda che ci poniamo non riguarda il valore dei contenuti – che riconosciamo e desideriamo – ma l’uso che se ne fa: stiamo assistendo a un reale tentativo di valorizzare saperi non convenzionali, o piuttosto a una risposta opportunistica a bandi e finanziamenti esterni che impongono agende e priorità? Proprio perché questi temi sono cruciali, il modo in cui vengono trattati conta: ridurli a una sfilata di interventi estemporanei, affidati di anno in anno a programmazioni instabili, rischia di svuotarli. È la logica tipica di un neoliberismo accademico che inserisce saperi “emersi dal basso” come elementi decorativi, sradicati da qualsiasi base sociale e comunitaria, pronti a scomparire non appena cambiano gli indicatori o le aspettative ministeriali. Noi desideriamo invece una costruzione condivisa che radichi questi saperi nella vita della Scuola e nella sua comunità, affinché non siano un ornamento progressista, ma una pratica viva, capace di trasformare modalità di apprendimento e forme del pensiero.
L’altra faccia di questa trasformazione è un altro elemento, apparentemente marginale ma rivelatore: l’insistenza, emersa negli ultimi mesi, sulla necessità di privilegiare relatori interni in nome della “continuità didattica”. Questa ci sembra da un lato una forma di pressione verso l’iper-specializzazione precoce, che vede nella linearità curricolare una prova di “serietà” e “produttività”; dall’altro, la riproduzione di dinamiche di fidelizzazione, in cui la costruzione di un rapporto privilegiato con chi detiene capitale accademico diventa garanzia di futuro accesso ai pochi spazi disponibili – dal dottorato ai progetti di ricerca. È una forma aggiornata di baronaggio, meno rumorosa ma non meno efficace, che si presenta come razionalizzazione amministrativa mentre riscrive le pratiche della cooptazione tradizionale. Tanto l’insistenza retorica sulla “continuità”, quanto la proliferazione di corsi da 3 cfu, ci appaiono come manifestazioni di un medesimo impoverimento: una didattica frammentata, che restringe di fatto gli spazi di scelta e di sperimentazione.
Infine, la stretta burocratica sui percorsi – la rigida separazione tra triennale e magistrale, la regolamentazione minuziosa dei passaggi tra seminari, il cambio di piattaforma da Serse a Esse3 – sembra testimoniare la volontà di delegare agli strumenti digitali e ai regolamenti il compito di definire ciò che possiamo fare, studiare, diventare. È un rovesciamento quasi distopico: non sono le esigenze formative a plasmare gli strumenti, ma gli strumenti a modellare la formazione.
Non si tratta, da parte nostra, di rivendicare un passato idealizzato. La Normale “di un tempo” non rappresenta per noi un modello a cui tornare: anche allora la formazione era segnata da gerarchie implicite, corsi talvolta improntati alla mera trasmissione erudita. Nostalgia e mercificazione sono due lati di una stessa incapacità di immaginare l’università come spazio creativo, rigoglioso, libero. Piuttosto, ciò che vogliamo aprire è una domanda condivisa sulla forma che la nostra istituzione potrebbe assumere: come configurare luoghi in cui la libertà di ricerca non sia retorica, ma pratica quotidiana? Come costruire relazioni pedagogiche che non siano né tutoring paternalistico né mera logica di competenze da acquisire? Questa domanda non ha una risposta preconfezionata; chiede tempo, conflitto, progettualità. Ma rinunciare a formularla significherebbe consegnare l’università alla gestione tecnocratica che oggi la svuota di senso.
