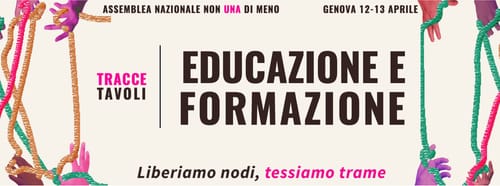
traccia tavolo EDUCAZIONE e formazione – assemblea nazionale genova 2025
Non Una Di Meno - Sunday, April 6, 2025
Modalità
Per favorire uno scambio più orizzontale si propone che la discussione del tavolo alterni momenti di discussione plenaria (inizio e fine dei lavori) a momenti di confronto in gruppi più piccoli, utilizzando una metodologia cooperativa.
Alla fine della discussione in gruppi si prevede 1 ora di restituzione in plenaria.
Temi
Approcci educativi reazionari, maschilisti, transfobici e classisti, questo è lo scenario che si apre davanti a docentə e studentə: a partire dall’osservazione dell’andamento politico degli ultimi tempi, delle decisioni dei ministri Valditara e Bernini, delle ripercussioni giuridiche subite da ormai numeros3 docent3 di tutti gli ordini e i gradi in diverse parti d’Italia. Saldamente in linea con le nostre proposte per una scuola transfemminista, abbiamo pensato di concentrare le nostre riflessioni su alcuni punti nevralgici, utilizzando i criteri di importanza rispetto ai nostri temi e di contingenza rispetto al presente.
Con l’intenzione di mantenere vigile l’attenzione su ciò che riteniamo importante ma anche su ciò che accade intorno a noi, abbiamo pensato di concentrarci su aspetti – seppur molto diversi tra loro – che riteniamo ora cruciali e non sacrificabili: educazione transfemminista all’affettività e alla sessualità, le nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del 1° ciclo, intimidazione e repressione sempre maggiori subite da studentə e docentə, militarizzazione e demilitarizzazione dei nostri istituti e delle Università, adeguamento stipendiale, poiché il salario delle docenti – già tra i più bassi d’Europa e pesantemente aggredito dall’inflazione negli ultimi anni – sia tale proprio perchè si considera l’insegnamento come il ‘naturale prolungamento del ruolo materno.
Proponiamo di concentrarci sui cambiamenti in atto nella scuola e nelle università mantenendo però una prospettiva di superamento dell’esistente, che tenga al centro i nostri bisogni, desideri e immaginari per un futuro diverso.
Nel dettaglio, alcune domande stimolo per ogni argomento sui cui ci piacerebbe riflettere utilizzando la modalità partecipata sopra indicata:
Educazione sessuo-affettiva
Le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del I ciclo definiscono nero su bianco la violenza di genere come una “triste patologia” negandone la natura strutturale che deriva da meccanismi e consuetudini alla base della nostra società. Questa è l’ultima delle tante affermazioni del governo sul tema della violenza di genere. In passato possiamo citare le linee guida per l’educazione civica ed altre proposte che tentano di declinare l’educazione sessuo-affettiva a scuola in chiave moralistica e patriarcale, come una mera questione di parità fra i generi (solo due, maschile e femminile). Non basta parlare di sentimenti e di gentilezza. Per intervenire sul problema è doveroso ragionare sui ruoli di genere, sull’autorità patriarcale sulla quale si fonda la società in cui viviamo. E’ necessario lavorare sulla violenza in tutte le sue forme, sul consenso, sul possesso, sulle idee preconcette e ben inserite nel senso comune che stanno alla base di relazioni affettive violente, sulla gestione ed espressione delle emozioni, sulla libertà di autodeterminarsi, di scegliere per sé stessə e sul proprio corpo. A ciò si aggiunge la ben nota crociata anti gender, in particolar modo con la proposta di legge della Lega contro uso del linguaggio neutro e contro carriere alias. In questo contesto è urgente discutere di educazione sessuo affettiva transfemminista e di educazione anti patriarcale.
Cosa significa per noi? Come pensare l’educazione sessuo-affettiva transfemminista in ottica di continuità dalla scuola dell’infanzia alla secondaria?
Su quali temi ci concentriamo e/o sarebbe necessario farlo? Quali esigenze emergono dal corpo studente? Quali momenti e spazi sfruttare? Quali strumenti didattici per inquadrare la proposta? Quali strumenti per dare corpo a questi progetti, contro le intimidazioni e i tentativi portati avanti da questo governo fiancheggiatore delle lobbies anti-scelta?
Di cosa ci sarebbe bisogno? Quali sono le esigenze di formazione del personale docentə? Quali alleanze possibili con realtà che si occupano di questi temi? Quali strumenti di tutela rispetto a progetti presentati da enti e associazioni vicine ai pro-vita che vogliono entrare nelle scuole?
Come si declina l’educazione sessuo-affettiva transfemminista all’università? Quali sono le esperienze e le prospettive concrete?
nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del I ciclo
La cifra di queste nuove indicazioni nazionali viene offerta già nella premessa, laddove la violenza di genere viene inquadrata e raccontata come una patologia e non come un fenomeno strutturale. Questa premessa, pericolosa e anacronistica, porta con sè una forte contestazione a uno dei cardini della prospettiva transfemminista di nudm: come dare risalto e rispedire al mittente questa pericolosa contestazione? Quali punti di forza agire per scardinarla?
Proseguendo all’introduzione del testo, le n.i.n. pongono al centro l’individuo come essere dotato di talenti da mettere a frutto, predominante rispetto alla comunità. Tale concezione ha le sue radici nella tradizione occidentale, dal diritto romano alla tradizione cristiana. In questo senso le nuove indicazioni nazionali considerano la proposta culturale occidentale come “neutra” e vanno in senso contrario agli studi socio-antropologici e politici decoloniali.
Tale visione della persona si basa su un riferimento culturale eurocentrico ed obsoleto essendo rivolta ad una scuola abitata da pluralità culturali, religiose, linguistiche e identitarie. Questa impostazione risulta escludente e limitata. Quale spazio trovano le identità non “occidentali”, non conformi, non-binarie- neurodivergenti?
Le indicazioni nazionali propongono una concezione dell’Identità che si costruisce sulla differenza dall’altro….perché non sulla somiglianza?
La costruzione dell’ identità a scuola si basa sull’appartenenza ad una storia cronologica e storico-culturale comune. Dato il contesto multiculturale della nostra scuola e della società, perché non scegliere come basi di costruzione dell’identità l’uguaglianza e i diritti?
La visione dell’insegnante come “Magister”, singolo individuo carismatico, non coincide con la realtà della scuola, formata da insegnanti che lavorano insieme, collaborano, si confrontano. E poi perché Maestro,quando la maggior parte delle persone che lavorano nella scuola sono donne?
Quale descrizione dell’insegnante riteniamo adeguata e in assonanza con la scuola contemporanea?
Perché, come suggeriscono le indicazioni nazionali, immaginare una relazione ristretta scuola-famiglia invece di allargare lo sguardo alla comunità educante?
Il valore della libertà viene posto al centro della formazione scolastica ma la libertà è intesa in senso individuale. Quale libertà possiamo praticare nella comunità?
Le indicazioni nazionali citano più volte il senso del limite come elemento chiave da acquisire a scuola. Non si parla dei bisogni degli studentə ma solo della necessità di guida e contenimento secondo il principio di autorità. Quali modelli di relazione possiamo contrapporre a questa narrazione?
Repressione docentə e studentə
Rispetto alle intimidazioni agite attraverso l’apertura di numerosi procedimenti disciplinari a carico dellə docenti qual è il quadro normativo di riferimento? Quali sono gli strumenti che abbiamo per tutelarci? Come ci fa sentire questa situazione? Come poter reagire?
Il voto in condotta e le misure integrate nei regolamenti d’istituto si rivelano come strumenti di repressione dell’attivismo studentesco. E’ emersa in maniera preponderante la mobilitazione dellə studentə mediə e universitariə contro autoritarismo e molestie. Quali sono state le esperienze positive?
Nella scuola dell’autonomia il ruolo dirigenziale o dello staff è predominante. Come contrastare quindi anche a scuola questi rapporti di forza e di potere? Quali strumenti abbiamo, se li abbiamo? Come possiamo agire in quanto docentə e studentə insieme? Come viene vissuta la repressione nel mondo studentesco e universitario? Quali sono le alleanze possibili? Quali gli obiettivi da perseguire insieme?
(de)militarizzazione
Sempre più frequenti sono gli ingressi delle forze dell’ordine nei nostri a volte in maniera dirompente ma spesso sottile e strisciante, sotto forma di orientamento nell’ambito dei PCTO, oppure di formazione rispetto a temi specifici come cyberbullismo e cybersecurity, quando non addirittura per parlare di violenza di genere. Ci sembra quindi urgente ragionare su cosa sta succedendo nelle nostre scuole e università, quali forme sta prendendo e come poter agire all’interno di questo contesto per invertire la rotta?
Riflettiamo sull’uso di un linguaggio bellico come unica metafora rispetto ai conflitti e alle stratificazioni della società che ci circonda. Possiamo demilitarizzare il linguaggio? Come e in quali occasioni?
Quali pratiche quotidiane possiamo portare a scuola in quanto docentə e studentiə contro la guerra e il riarmo? Ci sono esempi di attività concrete?
Come si muovono i collettivi studenteschi nelle scuole e nelle università? Quali alleanze possibili e su quali obiettivi concreti?
Esistono reti che lavorano per la demilitarizzazione della scuola. Come collaborare?
Restituzione in plenaria
Parole chiave/ obiettivi comuni/ buone pratiche.
Altri spunti
- Individuare gli spazi didatticamente grigi dove è possibile inserire interventi didattici mirati rispetto ai temi trattati (educazione sessuoaffettiva, demilitarizzazione della scuola e dei linguaggi, maggiore spazio alla modalità decoloniale nella proposta dei contenuti soprattutto umanistici), costruire una mappatura delle realtà che monitorano alcuni di questi aspetti, le ricerche in merito, etc…
- analisi e proposta di riforma del regolamento sull’uso social media per dipendenti pubblici – creazione di una controproposta da diffondere sui social?
- Creare una cartella condivisa in un drive dove poter rendere disponibili materiali/percorsi elaborati da singoli nodi
- Promuovere, eventualmente assieme ad altrə soggettə, mobilitazioni e campagne a partire da ciò che si sta attivando sulle indicazioni nazionali, evidenziando la centralità della critica alla violenza ‘come triste patologia’ e lo sfruttamento del lavoro docente (adeguamento dei salari)
- Scrivere un testo di analisi approfondito (una specie di prosecuzione/aggioramento del piano) che serva da piattaforma per il lancio delle mobilitazioni su scuola e formazione
