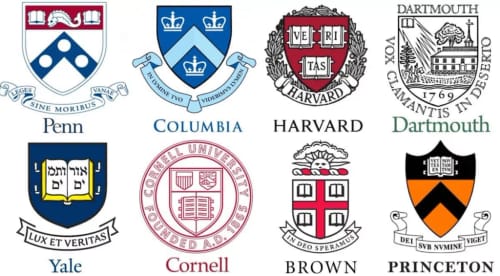
Università americane: l’internazionalizzazione diventa una linea di difesa?
ROARS - Monday, September 15, 2025Aprire campus all’estero può diventare una strategia per le università americane desiderose di sfuggire alle pressioni politiche dell’inquilino della Casa Bianca? Non è così certo… Costi nascosti, standard accademici difficili da mantenere, instabilità dei paesi ospitanti: queste sedi sono molto più fragili di quanto sembrino – e talvolta semplicemente insostenibili.
Sotto la crescente pressione dell’amministrazione Trump, alcune grandi università americane stanno ripensando la loro strategia internazionale. Quando la Columbia University (New York) accetta, nel luglio 2025, di modificare la propria governance interna, il codice disciplinare e la definizione di antisemitismo nell’ambito di un accordo extragiudiziale – senza decisione di un tribunale né legge votata – si tratta di molto più che di una semplice risoluzione di una controversia. È un precedente politico. L’ateneo newyorkese sancisce così una modalità di intervento diretto dell’esecutivo federale, al di fuori del quadro parlamentare, che erode l’autonomia universitaria sotto il pretesto di ripristinare l’ordine pubblico nel campus, accettando ad esempio l’ingerenza delle forze federali di polizia nel controllo degli studenti internazionali.
Lo stesso tipo di minaccia incombe da tempo su Harvard: restrizioni ai visti per studenti internazionali, potenziale blocco di finanziamenti federali, sospetti di inerzia di fronte alle mobilitazioni studentesche. In entrambi i casi, i più eclatanti e mediatizzati, l’amministrazione federale è intervenuta senza legiferare. Questo metodo «apre la strada a una maggiore pressione del governo federale sulle università», creando un precedente che altri istituti potrebbero sentirsi obbligati a seguire.
Un ridispiegamento parziale all’estero
Un tale offuscamento dei riferimenti giuridici trasforma in profondità un sistema universitario che si credeva solido e protetto: quello delle grandi istituzioni di ricerca americane. Ormai confrontate a un’instabilità strutturale, queste università prendono in considerazione un’opzione che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata incongrua: ridispiegarsi parzialmente fuori dagli Stati Uniti, non tanto per ambizione di conquista quanto per volontà di salvaguardia.
In questa prospettiva, il trasferimento parziale all’estero, tattica per alcuni, preludio di una nuova strategia per altri, si distingue dalle dinamiche di internazionalizzazione delle decadi passate. Georgetown ha appena prorogato di dieci anni la sua sede a Doha; l’Illinois Institute of Technology prepara l’apertura di un’antenna a Mumbai. Un tempo animati da un’ambizione espansiva, questi progetti assumono oggi un carattere più difensivo. Non si tratta più di crescere, ma di garantire la continuità di uno spazio accademico e scientifico stabile, affrancato dall’arbitrio politico interno.
Eppure, la storia recente invita a relativizzare questa strategia. Il Regno Unito post-Brexit non ha visto le sue università aprire massicciamente campus nel continente. In un contesto diverso, la London School of Economics, pur pioniera nell’internazionalizzazione, ha rafforzato i partenariati istituzionali e i doppi titoli in Francia, ma ha scartato l’idea di una sede offshore. Le università britanniche hanno preferito consolidare reti esistenti piuttosto che creare intere strutture all’estero, probabilmente consapevoli che un’università non si sposta come un’impresa.
La Francia in testa con 122 campus all’estero
I campus internazionali sono spesso costosi, dipendenti, fragili. Il rapporto Global Geographies of Offshore Campuses recensiva nel 2020 ben 487 sedi di istituti d’istruzione superiore al di fuori del loro paese d’origine. La Francia è in testa con 122 campus all’estero, seguita dagli Stati Uniti (105) e dal Regno Unito (73).
Le principali aree di accoglienza si concentrano in Medio Oriente e in Asia: Emirati Arabi Uniti (33 campus, di cui 29 a Dubai), Singapore (19), Malesia (17), Doha (12) e soprattutto la Cina (67) figurano tra gli hub più attivi. Per i paesi ospitanti, queste sedi si inseriscono in strategie nazionali di attrattività accademica e di ascesa nell’istruzione superiore. Il loro successo si spiega meno con garanzie di libertà accademica che con incentivi economici, fiscali e logistici mirati, oltre che con la volontà dei governi locali di posizionare il proprio territorio come polo educativo regionale.
Il Golfo offre un contrasto sorprendente. Da oltre vent’anni, Emirati Arabi Uniti e Qatar attirano istituzioni prestigiose: New York University (NYU), HEC, Cornell, Georgetown. Questi campus sono il prodotto di una politica volontaristica di attrattività accademica, sostenuta da Stati ricchi desiderosi di importare capitale scientifico e simbolico. L’Arabia Saudita segue ora la stessa strada, con l’annuncio dell’apertura del primo campus straniero di un’università americana (University of New Haven) a Riad entro il 2026, con l’obiettivo di accogliere 13.000 studenti entro il 2033.
In Asia nord-orientale, nessun paese – Cina, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Singapore – ha preso in considerazione l’idea di ospitare un campus americano in risposta alle recenti tensioni. Al contrario, diversi cercano di attrarre studenti e dottorandi penalizzati, in particolare quelli di Harvard.
A Hong Kong, università come HKUST o City University hanno introdotto procedure di ammissione accelerate e semplificate. Tokyo, Kyoto e Osaka offrono borse di studio ed esenzioni dalle tasse. Queste iniziative, che appartengono a una strategia di sostituzione, poggiano su due fattori strutturali: un investimento pubblico sostenuto nell’istruzione superiore e la presenza di un notevole bacino scientifico asiatico nelle università americane, che facilita i trasferimenti. In questo senso, l’Asia-Pacifico appare oggi come uno dei principali beneficiari potenziali del clima di incertezza politica negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti, il segno di un cambiamento discreto
La mappa dei campus offshore rivela un paradosso storico. Fino a poco tempo fa, le università del Nord globale aprivano sedi in paesi dove la libertà accademica non era necessariamente più garantita (Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Cina, Qatar…), ma dove trovavano stabilità amministrativa, incentivi finanziari e accesso agli studenti della regione. Era una strategia di espansione, non di ripiegamento, come oggi, di fronte a un’incertezza politica crescente.
L’idea resta marginale, sussurrata in pochi circoli dirigenti. Ma basta a segnalare un cambiamento discreto: quello di istituzioni che cominciano a guardare oltre i propri confini, meno per ambizione che per inquietudine. Tuttavia, l’internazionale non è né un santuario né uno spazio neutro: attraversato da sovranità, regole e norme, può esporre ad altre forme di vincoli.
La Sorbona Abu Dhabi, inaugurata nel 2006, risponde a una logica inversa: un’università francese insediata nello spazio del Golfo, su invito del governo di Abu Dhabi, in un quadro contrattuale e di cooperazione bilaterale che riafferma, nel tempo, la capacità di proiezione mondiale di un modello accademico nazionale. Questa iniziativa non mirava a proteggere uno spazio accademico minacciato: al contrario, incarnava una strategia d’influenza dichiarata, in un ambiente istituzionale controllato.
Niente di simile nelle attuali riflessioni americane, dominate invece dalla logica dell’elusione. Tuttavia, i limiti del ridispiegamento sono già ben noti.
Sedi fragili
I campus delocalizzati soffrono di una bassa produttività scientifica, di un’integrazione accademica parziale e di forme di disaffiliazione identitaria tra i docenti espatriati.
Philip G. Altbach, figura di riferimento tra gli esperti di istruzione superiore transnazionale, da tempo sottolinea la fragilità dei modelli delocalizzati; l’esperto britannico Nigel Healey ha identificato problemi di governance, di adattamento istituzionale e di integrazione dei docenti. L’esempio più recente dell’India mostra che molti campus stranieri faticano a superare lo status di vetrine, senza un reale contributo duraturo alla vita accademica locale né una strategia pedagogica solida.
A queste debolezze strutturali si aggiunge una questione poco affrontata apertamente, ma decisiva: chi pagherà per questi nuovi campus fuori dagli Stati Uniti? Un campus internazionale rappresenta un investimento considerevole, tra edifici, sistemi informatici, risorse umane e accreditamenti. L’apertura di una sede stabile richiede diverse centinaia di milioni di dollari, senza contare i costi di gestione. In un contesto di tensione crescente sui bilanci, di calo degli investimenti pubblici nell’istruzione superiore e di reterritorializzazione dei finanziamenti, non è facile individuare attori – pubblici, filantropici o privati – disposti a sostenere università americane fuori dal loro ecosistema.
Quando la NYU si insedia ad Abu Dhabi o la Cornell a Doha, ciò avviene con il massiccio sostegno di uno Stato ospitante. Questa dipendenza finanziaria non è priva di conseguenze. Espone a nuove pressioni, spesso più implicite, ma altrettanto efficaci: controllo dei contenuti insegnati, orientamenti della ricerca, selezione congiunta dei docenti, autocensura su argomenti sensibili. In altre parole, voler sfuggire a una pressione politica attraverso l’esilio può talvolta esporre a un’altra. La libertà accademica spostata non è che un miraggio, se poggia su un modello di finanziamento tanto precario quanto politicamente condizionato.
Mobilità accademica e libertà di ricerca
In un recente rapporto del Centre for Global Higher Education, il sociologo Simon Marginson mette in guardia da una lettura troppo strumentale della mobilità accademica. Non sono i luoghi, ma i contesti politici, sociali e culturali a garantire o a indebolire la libertà universitaria. Il rischio maggiore è la dissoluzione del quadro democratico che ancora permette all’università di pensare, ricercare e insegnare liberamente.
Di fronte a questo spostamento delle linee, l’apertura di un campus all’estero non può essere che un gesto provvisorio, un tentativo incerto in un mondo già attraversato da altre forme di instabilità.
Ciò che l’istruzione superiore affronta oggi non è soltanto la minaccia di un potere politico nazionale, ma l’indebolimento dello spazio in cui può ancora esercitarsi un pensiero critico e condiviso. Alcuni osservatori, come lo storico Rashid Khalidi, vi vedono il segno di uno slittamento più profondo: quello di università che, cedendo alla pressione politica, diventano «luoghi di paura», dove la parola è ormai condizionata dal potere disciplinare.
La sfida non è solo preservare una libertà. È mantenere una capacità di agire intellettualmente, collettivamente, all’interno di un mondo che ne restringe le condizioni.
